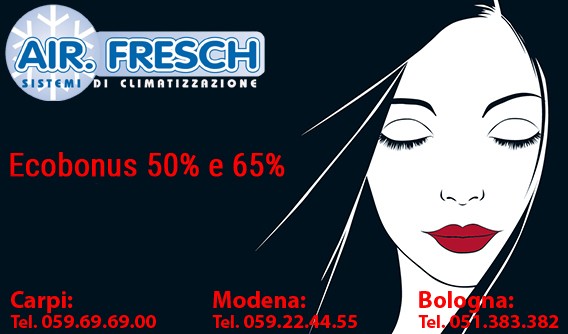L’incantesimo di Don Chisciotte
di Luciana Saetti
Una vita movimentata e difficile quella di Miguel de Cervantes, venuto giovanissimo in Italia dalla Spagna al seguito di un prelato, entrato a poco più di vent’anni in una compagnia militare, ferito a Lepanto (1571) dove perde l’uso della mano sinistra e, dopo altre battaglie contro i Turchi e alcuni anni a Napoli, catturato e fatto schiavo dai pirati barbareschi mentre sta tornando in patria. Una dura prigionia di cinque anni ad Algeri e infine, nel 1580, il riscatto e la libertà: ma in una Spagna ormai avviata alla decadenza politica ed economica dove lo aspettano, nella frustrazione delle sue aspirazioni letterarie, anni di ristrettezze economiche, impieghi amministrativi e frequenti trasferimenti (Valenza, Siviglia, Toledo, Valladolid, Madrid). Vive con le sorelle, la moglie da cui poi si separerà, una figlia avuta da un’attrice.
I fatti esteriori sfumano in zone d’ombra: conosce di nuovo, e più volte, la prigionia per presunti illeciti amministrativi come esattore delle imposte, poi perché sospettato dell’uccisione di un cavaliere sotto casa sua. Nel 1605, a cinquantotto anni, pubblica il romanzo, probabilmente scritto in carcere, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: immediato successo ma scarsissimi riscontri economici. Gli ultimi anni spesi a rimettere mano ai propri scritti giovanili e ai più recenti, novelle, commedie, poesie, per darli alle stampe.
Nel frattempo lavora alla continuazione del Don Chisciotte, il cui successo ha suggerito a qualcuno di pubblicarne, sotto pseudonimo, un sequel pirata. Nella prefazione alla seconda parte del romanzo, dieci anni dopo la comparsa della prima, sconfessa lo sconosciuto plagiario e presenta al lettore non solo “un don Chisciotte accresciuto” ma “alla fine, morto e seppellito, finché nessuno si arrischi a produrgli nuovi testimoni”.
Cervantes muore poco tempo dopo aver concluso il proprio capolavoro, il 22 aprile 1616, esattamente quattrocento anni fa, e una decina di giorni prima di William Shakespeare.
L’invenzione di Cervantes dà vita a quello che è considerato il primo grande romanzo moderno. Nella vicenda di don Chisciotte è viva la traccia del disinganno dell’autore, in un clima “di solitudine esistenziale, d’insofferenza verso i vincoli ambientali e inquisitoriali, di dissidenza verso le ingiuste istituzioni”, come osservava il critico Dario Puccini, avvertendo però che le reticenze e le cautele di Cervantes, e l’alto grado d’ironia del romanzo “non consentono eccessive o avventate semplificazioni”.
Chi legge il Don Chisciotte se ne accorge immediatamente: Cervantes sviluppa la vicenda in una multiforme varietà di situazioni e personaggi, di motivi e di registri, mescolando con mano sicura generi letterari diversi, moltiplicando e rovesciando le prospettive, e ha tutta l’aria di spassarsela alla grande inventando, sotto il segno dell’umorismo e del depistaggio, procedimenti a scatole cinesi, racconti nel racconto, deragliamenti del senso comune, paradossi vertiginosi. Costruisce, nella sostanziale ambiguità dei significati, un racconto variopinto e brioso, dove il match vita-letteratura, realtà-illusione, verità-finzione si trasforma in un gioco di specchi. Per questo il Don Chisciotte è irriducibile a un’interpretazione univoca e si propone al lettore con la modernità di un’opera aperta.
Complicato, divertente, spiazzante, il romanzo si propone come una parodia dei libri di cavalleria che l’autore dichiara di avere in odio ma di cui è invece un appassionato lettore il protagonista: “In un borgo della Mancha, il cui nome non mi viene a mente, non molto tempo fa viveva un cavaliere...”. Siamo nella Spagna di Filippo II, del cupo e maestoso Escorial, dell’Inquisizione, del disastro dell’Armada invencible; e lui è l’hidalgo Alonso Quijano. La sua condizione è quella di una piccola nobiltà le cui rendite ormai bastano a ben poco; vive nella campagna spopolata d’una provincia fuori mano ed è un uomo ormai vecchio, alle soglie dei cinquant’anni, il cui equipaggiamento di cavaliere pende in disuso in qualche angolo della casa. Nella stasi di un’esistenza chiusa e monotona, passa il tempo immergendosi nella lettura dei romanzi cavallereschi che ha raccolto nella propria biblioteca monotematica – indubbio segnale di maniacalità, tra passione e squallore, a seconda di come la si vuol vedere.
Sta di fatto che queste smodate letture gli stravolgono il cervello: è un motivazione comica quella che inventa Cervantes per far scattare il meccanismo dell’avventura. Di punto in bianco, l’uomo assennato e benevolo che è Alonso Quijano parte per la tangente, posseduto dalla fissazione di rivivere l’epica dei cavalieri erranti, modelli di valore guerriero e nobiltà d’animo. La sua è una follia “ingegnosa”: comincia con il darsi un altro nome, don Chisciotte della Mancha, e dopo lunghe riflessioni ne trova uno adatto anche per il suo cavallo, e per colei che elegge a “signora dei suoi pensieri”, una piacente contadina del vicino villaggio che ricorda solo vagamente, e che diventa Dulcinea del Toboso: “nome che gli parve musicale, peregrino e significativo”. Prepara tutto minuziosamente, ripulisce le armi arrugginite, aggiusta la celata, e come ogni ideale cavaliere errante parte senza una meta, va alla ventura in una dimensione stralunata, impermeabile alla realtà effettiva, dura e mediocre, e alle reazioni altrui. Un matto, come si suol dire, alla cui esaltazione visionaria fa da contraltare il gretto realismo della gente comune: e tutto avviene nella totale incomunicabilità tra questi due mondi.
Nella sua fissazione, don Chisciotte vede un castello dove c’è un’osteria, vede in un gregge di pecore un gruppo di cavalieri nemici, pericolosi giganti in innocui mulini a vento; tutti gli altri, locandieri e serve, contadini, studenti, vagabondi, vedono un uomo strambo e ridicolo, ma che a volte li lascia a bocca aperta quando esalta, con un linguaggio elegante e fiorito, la nobile civiltà della cavalleria; salvo poi essere caricato di botte ogni volta che i suoi slanci cavallereschi s’incrociano malamente con le normali occupazioni altrui.
C’è poi chi, preoccupato, fa di tutto per guarirlo dalla sua mania, soprattutto i vecchi amici: il curato e il barbiere, due benpensanti che, dopo averlo riportato a casa con un recupero coatto, decidono di bonificare la sua biblioteca procedendo a una cernita che si risolve nel buttare in cortile tutti quei libri per farne un falò; e per finire, fanno sparire addirittura la stanza murandone la porta.
Tra quei libri ce n’è anche uno di Cervantes: “Da molti anni è mio amico codesto Cervantes, e so che è più versato in disgrazie che in versi. Il suo libro è piuttosto buono come intreccio, si propone qualcosa e non conclude nulla; bisogna aspettare la seconda parte annunziata da lui” sentenzia il curato; nel frattempo il barbiere terrà quel libro sotto chiave in casa sua. Nel romanzo di Cervantes, dunque, si parla di un romanzo di Cervantes. Nel secondo volume si parlerà del primo, già pubblicato e già letto da quasi tutti i personaggi che don Chisciotte incontra nelle sue nuove avventure; vi compare anche il sequel contraffatto, che lui stesso vede in una stamperia di Barcellona. Siamo, insomma, in quella che è stata definita la “quarta dimensione” della letteratura (tecnicamente, metaletteratura) inaugurata da questo grande autore: una fuga di specchi in cui realtà e illusione si rincorrono all’infinito.
Cervantes è così: confonde le carte. Gioca ambiguamente anche sulla fonte delle vicende che racconta, dicendo di aver ricavato la storia di don Chisciotte da notizie scovate negli archivi della Mancha, di averla continuata grazie al fortunoso ritrovamento, in un bazar di Toledo, di certi scartafacci di uno storico arabo, fin troppo preciso nei dettagli ma che a volte mette in dubbio la veridicità del proprio stesso racconto; e di esserseli fatti tradurre in castigliano da un morisco, un musulmano convertito, che vi ha inserito, di testa sua, delle correzioni.
Quanto ai romanzi cavallereschi, non c’è dubbio che Cervantes se la prenda con i libri mal scritti, con il cattivo gusto della letteratura dell’eroismo e della galanteria diventata un genere d’intrattenimento alla moda. Ma se il tempo dell’epica è irrimediabilmente finito, non lo è il mondo ideale della poesia che lo ha creato. Volerlo vivere e far vivere è un sogno folle, un’illusione ridicola, ma è anche un atto poetico, perché don Chisciotte crea da sé quel mondo in cui si riconosce, autentico e fittizio al tempo stesso: un po’ come un romanzo. Anzi, come “l’immenso romanzo di illusioni” (C. Noteboom) che è El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
L’icona di don Chisciotte che si è tramandata fino a noi tende alla caricatura: il vecchio ronzino, l’equipaggiamento raffazzonato alla meglio, il profilo secco e allampanato, la fisionomia indistinta e ingrigita come da sbaffi di cenere. Anche la coppia don Chisciotte-Sancho tende a ridursi all’eterno stereotipo del contrasto tra due compari, il magro spilungone e il grasso piccoletto, il nobile e il villano, l’astuto e il tonto eccetera.
La battaglia contro i mulini a vento è diventata proverbiale come il suo protagonista: si dice che è “un don Chisciotte” qualcuno che si butta a testa bassa in un’impresa impraticabile, un illuso, totalmente sprovvisto di senso della realtà: “Ma sei fuori?” pensano gli altri, compreso il fido scudiero che lo vede partire al galoppo con la lancia in resta. È questa l’immagine di don Chisciotte che, come una figurina ritagliata da un libro perduto, si è fissata nel nostro immaginario con i tratti comici e grotteschi del perdente, in cui però è possibile vedere anche quelli romantici dell’idealista generoso e tragico. C’è chi ha voluto riconoscere in lui la figura della redenzione spirituale e chi ha sottolineato il “comico scompiglio” prodotto dalle sue imprese; qualcuno vi ha visto la crudeltà del mondo nei confronti del diverso, altri hanno messo a fuoco, nello sdoppiamento del personaggio Alonso-Chisciotte, le dinamiche del conflitto interiore. Nell’inesauribile molteplicità delle letture critiche si riflette la straordinaria ricchezza di significati dell’opera.
Alla dimensione visionaria in cui è proiettato don Chisciotte fa da contraltare il richiamo di Sancho alla realtà (“Ma sono dei mulini!” gli grida disperato) che il cavaliere nemmeno sente. E sono altrettanto inefficaci gli insegnamenti sulle virtù cavalleresche nei quali don Chisciotte si diffonde in ogni occasione con lo scudiero. Strada facendo, però, tra i due si instaura un legame diverso: a poco a poco Sancho s’immedesima, a suo modo, in don Chisciotte e nel suo sogno. E don Chisciotte trova un conforto nella sua controparte. In questa dinamica di coppia si arriva al rovesciamento di prospettive: siamo nella seconda parte del romanzo quando, per soddisfare come può i desideri e gli ordini di don Chisciotte, Sancho gli presenta come Dulcinea con le sue damigelle tre ragazze del villaggio incontrate per caso. Ma qualcosa non funziona: “Io non vedo altro, Sancho” disse don Chisciotte “che tre contadine sopra tre asini”.
Anche se Sancho insiste a esaltare, raffazzonando il linguaggio più nobile e alto di cui è capace, la bellezza sublime della dama, e quasi si convince della propria finzione, l’impatto con la realtà lascia il cavaliere deluso e incredulo. Poi interviene, come altre volte, l’autoinganno: questo, si convince don Chisciotte, dev’essere l’incantesimo d’un mago invidioso, che ha messo “nubi e cateratte” nei suoi occhi, e trasformato al suo sguardo Dulcinea in una qualunque campagnola. Ma l’ingegnosità dell’illusione è a doppio taglio, perché allora, forse, è lui stesso la vittima dell’incantesimo: don Chisciotte dubita della propria percezione e della propria identità. Il mondo dell’illusione comincia a sgretolarsi.
In che cosa consiste la “particolare luce cervantesca” che illumina il romanzo? A che cosa si deve la tenuta di questa vicenda strampalata, che gioca con l’ordine e il disordine del mondo? Secondo Erich Auerbach (Mimesis, 1946), si tratta di “un contegno”, un modo coraggioso e impassibile di porsi di fronte al mondo e quindi anche all’oggetto della propria arte: Cervantes “vede, dà vita, si rallegra a questo gioco, che deve anche rallegrare in modo educato il lettore”, ma senza prendere partito, tranne che contro i libri mal scritti; rimane neutrale, non giudica e non trae conclusioni.
E per noi che lo leggiamo adesso, qual è l’“effetto Cervantes”? Che cosa si muove in noi, di fronte alla totale felicità della sua opera? Nei suoi ultimi giorni, don Chisciotte torna a essere Alonso Quijano; ma è diventato un pentito, che sconfessa “tutte le odiose storie profane della cavalleria errante”. Quando Sancho, sconsolato, si accosta al suo letto, gli chiede perdono: “Perdonami per averti messo nella condizione di sembrare pazzo come me, facendoti cadere nell’errore in cui io sono caduto, cioè che vi siano stati e vi siano cavalieri erranti nel mondo”. Al suo capezzale si volgono, retrospettivamente, gli sguardi delle Bovary e dei principi Myškin; mentre Sancho, semplicemente, non si sa rassegnare:
“Ah!” rispose Sancho, piangendo. “Non voglia morire la signoria vostra, signor mio, ma accetti il mio consiglio e campi molti anni, perché la maggior pazzia che un uomo può fare in questa vita è lasciarsi morire così, su due piedi, senza che nessuno l’uccida e non lo finisca altra mano che quella della malinconia”.
Sì, la malinconia.
Nella foto, Pablo Picasso, Don Quixote de la Mancha





-1.jpg)