Il 7 Aprile ho compiuto cinquant’anni (e qui siamo già all’ottanta, novanta per cento di “chissenefrega”). Ricorrenza liminare, da spartiacque, che avrebbe richiesto e ottenuto, in tempi normali, celebrazioni da bicentenario della Bastiglia. Con il Covid, invece, tutti in casa, abbastanza mesti. È stata la seconda esperienza consecutiva di compleanno in lockdown. Ad Aprile 2020 era prevalso, però, il gusto paradossale della novità (famiglia ristretta, atmosfera intima e calda, in fondo non è male nemmeno così, possiamo essere felici con poco, eccetera). Per i cinquanta, invece, i sorrisi sono stati più simili a spasmi nervosi, gli auguri sussurrati a mo’ di sospiro, e giusto per non farsi mancare nessuna cabala negativa il numero 5 in marzapane issato sulla torta si è spezzato prima del taglio (roba che un aruspice romano c’avrebbe fatto abdicare l’imperatore, come minimo).
Un po’, lo dico a denti stretti, me lo merito. Anni e anni a fare il minimalista guastafeste, ma cosa ci sarà mai da celebrare, non osate farmi delle sorprese, i regali vanno bene per i bambini, e così via, scetticheggiando, e alla fine il contrappasso è stato cucinato e servito. Volevi la festicciola da groppo in gola, stile Germania dell’Est, o film di Kaurismaki, con i famigliari eroicamente impegnati a colorare di entusiasmo uno scenario ingrigito dalla pandemia e dalle restrizioni? Eccoti accontentato. Ovviamente da finto sociopatico quale sono adesso rosico perché mi è toccato sul serio, e non per celia o provocazione, festeggiare – per così dire – il genetliaco in un’atmosfera da comunità puritana del milleseicento e rotti, in cui ridere, ballare, bere è proibito e colpevole. Inutile sottolineare che, il prossimo anno, alla facciazza della reputazione e della morigeratezza dei costumi, se tutto va come deve andare (ripeto, con voce sempre più baritonale, e scongiuri di ogni tipo, se tutto va come deve andare) mi butto nelle fontane e gioco in acqua con le schiume colorate, come se fossi a Ibiza.
Intanto però ho raggiunto, secondo immagine consolidata, non il mezzo del cammino (magari...) ma, diciamo, il valico anagrafico dopo il quale tutto, in positivo e in negativo, dovrebbe andare in discesa. E la prima cosa che mi è venuta in mente – non credo si sia trattato di un’allucinazione personale e originale – è che quando di anni ne avevo dieci (ma anche venti o trenta) mica me li immaginavo così come sono io adesso, i cinquantenni. Per me, da bambino, in generale, gli adulti erano grandi, grandissimi, nel senso che li vedevo alti anche quando non andavano oltre il metro e sessantacinque, e se mi dicevano che uno aveva mezzo secolo di vita alle spalle non potevo raffigurarmelo se non meditabondo sui casi dell’esistenza e buono soprattutto a dispensare suggerimenti e raccomandazioni – anche un po’ pallose e anacronistiche – alle generazioni (figli, nipoti) che stavano fiorendo. Io, insomma, uno con cinquant’anni non me lo immaginavo più in movimento, ma statico, un dagherrotipo, al massimo un’istantanea, di sicuro non un film d’azione.


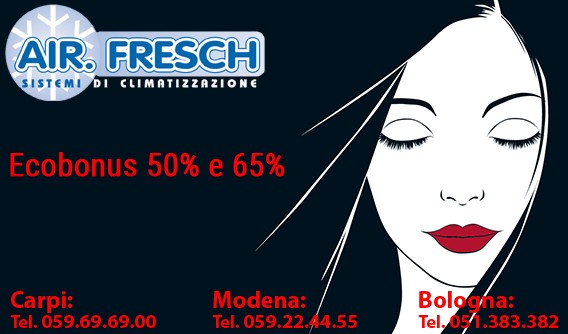



-2023-con-fotoOK-4.jpg)


