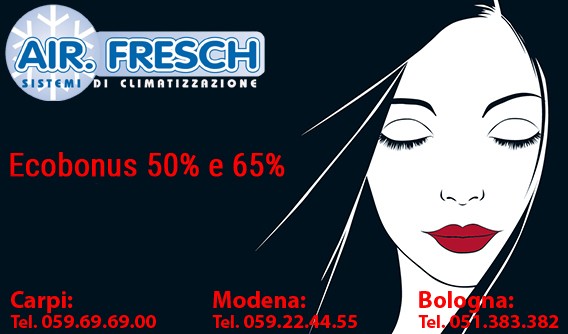Confesso: faccio un po’ fatica. Faccio un po’ fatica, anche se, essendo un insegnante, dovrei andarci a nozze, ma tutta questa sbornia da valutazione – metti tre stelle qui, scrivi un nove per quel servizio là, piazza un like sotto questo post, boccia l’ultimo ristorante in cui sei andato – mi mette alle strette, mi fa sentire un mezzo despota, insomma, sarò all’antica, ma stavo meglio quando si stava peggio, e l’utente-cliente non aveva tutto questo potere di vita e di morte sui fornitori di beni e servizi.
Sermoncino storico (diciamo così): tutta la modernità consiste in un lento, inarrestabile, processo di costruzione dell’io, del soggetto, con i suoi pensieri, le sue percezioni e passioni, come realtà sovrana e inimitabile, si parte da Cartesio e si arriva alla Ferragni, per arrivare a dire che l’ego non è una escrescenza, una patologia, ma il centro dell’universo, non importa chi, cosa, dove e quando sei, ciò che conta è il tuo personale, personalissimo, ragionare e sentire. Quindi nel momento in cui il Tripadvisor di turno, o il nostro gestore telefonico, ci chiedono di esprimere un giudizio su una struttura o su una utilità fornita da un provider, essi non fanno altro che vellicare quel re o quella regina – di nome “Io” – che ha reso, da mezzo millennio a questa parte, con una gradualità a volte esasperante (prima solo gli aristocratici, poi tutti i colti, a seguire i maschi nel loro complesso, infine tutte le donne, a lungo considerate eterodirette dalla ingombrante fisiologia), il mondo un posto più variegato e colorato, ma anche molto più caotico, in cui ogni individuo è (o meglio, pensa di essere) un pezzo unico, irriproducibile, con proprie, peculiari, volizioni e propensioni.
Ci mancava solo il tessuto della società digitale per fare il salto quantico: non solo tutti e tutte si sentono nelle condizioni di giudicare, discrezionalmente e autonomamente, qualsiasi aspetto della vita materiale e immateriale, dalla visita ortodontica al nuovo brano di Dua Lipa, ma ora vengono messi nella condizione di farlo effettivamente, di mettere davvero un pollice verso, di rifilare un quattro punitivo, di coprire di lodi o di infamia i loro simili, e il bello (ovvero il brutto) è che svolgono il compitino ferale con voluttà e senza ritegno.
La valutite acuta – la sindrome, in sostanza, per cui prima di capire che cosa ho mangiato, osservato, maneggiato, mi viene chiesto e mi autoimpongo di esprimere il personale, impressionistico, giudizio sull’oggetto – ha sostituito la più notabilare società del riconoscimento: un tempo, in regime di timocrazia, le persone si attestavano vicendevolmente colpe e meriti, vizi e virtù, e soprattutto ruoli sociali e parentali, nella comunità e nella famiglia, mentre adesso si danno di spada l’un con l’altro a colpi di “mi piace” e “non mi piace”, di pagelle su tutto, anche su come saluta il povero addetto dell’Ufficio relazioni con il pubblico, e la cosa triste e preoccupante è che gli esiti di queste sciabolate valutative vengono spesso prese per oro colato da parte di analisti e addetti al monitoraggio. Per cui se, per dire, mi viene il prillo di far licenziare una persona o mandare in rovina una farmacia è sufficiente che la metta giù dura per tre o quattro volte, magari con identità elettroniche diverse, negli spazi pubblici di rating, e il gioco è fatto.
Magari i nostri figli e nipoti capiranno che, sotto le parvenze dell’innocenza semi-ludica, questa società del giudizio (non nel senso che ha messo giudizio, ma a voler intendere che spara giudizi a raffica e vanvera) nasconde uno stato di ferinità e cattiveria degno dei bestioni di 2001. Odissea nello spazio. E si daranno, figli e nipoti, codici comportamentali, valori, etiche, e leggi, anche delle leggi, per arginare la facilità irresponsabile con cui ciascuno, vittima e carnefice a turno, può demolire in un nanosecondo il lavoro, o le speranze, o le certezze, di una vita altrui. Oggi, però, nel mentre, vale tutto (nel senso che ognuno dà responsi sullo scibile alla vacca boia e ogni cosa o persona che svolga una qualche funzione minimamente collettiva può essere allo stesso tempo sulle stelle e nelle stalle); e chi, come me (a proposito di quello che dicevo in apertura), lavora nel campo dell’educazione e della formazione, e sa quanto sia difficile e innaturale, seppur necessario, valutare, beh, al cospetto di questa orgia di voti e veti, non si diverte per nulla, e pensa semmai di essere finito in un incubo distopico.
Non c’è pezza: se penso di esistere non in quanto soggetto deambulante, o raziocinante, o desiderante, ma, prima di tutto, come grande inquisitore e sommo magistrato delle vite, dei corpi, delle azioni dei miei simili, non ci sarà freno al delirio valutativo, vivrò di feedback, di scale di merito, di “lascia la tua opinione”, senza un criterio, e senza un fine che non sia quello, attraverso il giudizio permanente effettivo, di sentirmi vivo.
Non percepirò più – almeno questa è l’evidenza del tempo presente, girovagando fra piattaforme e social – nemmeno il senso del ridicolo (opposto coincidente delle possibili, tragiche, conseguenze di certe opinioni tranchant rilasciate con noncuranza). Passi per quello che eccepisce, in rete, su “Il grande dittatore” di Chaplin perché, testuale, “il protagonista vuole la scena tutta per sé”. Ma che dire del mio, nostro, pari che, su un noto sito di vendita di libri on line, mette cinque stelle (il massimo) alla Montagna incantata di Thomas Mann dato che – anche qui è letterale – “il romanzo mi è arrivato a casa ben imballato e in soli due giorni”?