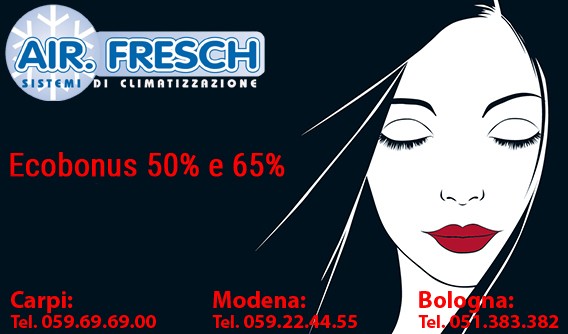Avrei potuto intitolare questo articolo Parole parole, oppure Bla bla bla, quello che conta è che questa volta mi preme scrivere su un fenomeno del nostro tempo che gli storici, fra qualche centinaio di anni, guarderanno con grande interesse, ma che oggi rischia di minare le fondamenta della nostra convivenza. Mi riferisco alla patologia, dalla quale evidentemente non sono immune neanche io (sennò non sarei qui, a fare una rubrica), della incontinenza verbale, la malattia, caratteristica delle nostre società complesse, che ha come sintomo principale il diluvio di parole, in tutti gli ambiti, da quello familiare a quello professionale, senza particolari distinzioni fra mondo materiale e mondo virtuale, fra la vita concreta delle strade e delle piazze e quella digitalizzata delle piattaforme e delle reti.
Da dove possa derivare questa sindrome, che si traduce nel fatto che tutti i giorni, tutti noi, indifferentemente vittime e aguzzini, produciamo e subiamo al contempo tonnellate di vani verbiloqui prodotti e distribuiti in tutti i contesti possibili immaginabili, non è facile da dire. Però qualche indizio ce l’abbiamo, e dico subito che la cosa abbastanza inquietante è che la diffusione velenosa e pandemica della parola (abusata e trasformata in una specie di agente virale, che invece di contribuire alla chiarezza e alla comunicazione non fa altro che riempire, pateticamente, vuoti di senso e di valori) è, come accade molto spesso, il frutto paradossale della convergenza e della sintesi di tanti presupposti in sé virtuosi. (segue)
Il primo di tali presupposti è costituito dalla facilità tecnica, supportata dagli strumenti, di emettere e di ricevere parole, perché rispetto alle società tradizionali noi abbiamo, al presente, la possibilità di far arrivare le nostre produzioni verbali, in voce o per iscritto, a miriadi di interlocutori, anche a un sacco di gente che non conosciamo, all’interno di una dinamica progressiva che è iniziata con la scrittura, si è poi potenziata mediante la stampa, il telefono, la radiofonia, fino ad arrivare, appunto, agli strumenti della rete. Naturalmente, in maniera simmetrica, non solo siamo in grado di far arrivare qualsiasi cosa a platee vastissime, ma queste stesse platee sono composte da soggetti che detengono il medesimo potere, a volte anche insospettabilmente: vivono in paesi molto arretrati, o appartengono a generazioni ancora molto acerbe, ma questo potenziale di comunicazione verbale urbi et orbi ce l’hanno, eccome.
La seconda variabile che ha determinato l’intasamento verbale delle nostre esistenze è l’affermazione sacrosanta, da un certo momento storico in poi, del diritto di espressione, della titolarità della parola come prerogativa giusta e naturale. Facciamo fatica a capire quanto la parola fosse conculcata, oppressa, letteralmente silenziata, in epoche precedenti alla contemporaneità, e non si tratta semplicemente di fare riferimento ai proverbiali secoli bui, o a contesti di repressione socio-politica, no, pensiamo ai silenzi millenari e coatti delle donne, ai silenzi obbligati in contesti patriarcali - ancora resistenti ma evidentemente destinati, per fortuna, alla sconfitta - nei tempi che hanno preceduto la soggettivazione della componente femminile e la sua emersione nella società.
Terzo e ultimo presupposto, anch’esso virtuoso, virtuosissimo, ma concorrente al risultato finale, tutt’altro che benefico, della verbodemia, dell’ipertrofia verbale del presente, è l’aumento del livello medio di scolarizzazione e di acculturazione. Questo è un argomento facilmente fraintendibile, è abbastanza evidente che fra il sottoscritto e un maestro erudito del Cinquecento, per dirla con un esempio piuttosto sgarrupato, c’è un gap lessicale spaventoso, a mio discapito. Ma se guardiamo alla società nel suo complesso è altrettanto intuitivo che non c’è paragone - per quanto noi oggi parliamo male, scriviamo ancora peggio, e facciamo fatica ad ascoltare, e leggiamo senza capire (vado avanti?) - fra il repertorio espressivo di un individuo comune di cinque secoli fa e quello odierno. La differenza in meglio è stata prodotta, e viene sistematicamente alimentata, dalla scuola e dai mezzi di comunicazione di massa, sicché anche le persone più pigre, più isolate, più deprivate culturalmente sono comunque inserite, oggi, in contesti traboccanti comunicazione verbale, e qualcosa, anche senza volere, se lo portano a casa. (segue)
Ecco, allora, che arriviamo in fondo, per vedere come tre ingredienti prodigiosi - la tecnologia potenziata della comunicazione verbale, i diritti acquisiti di comunicare verbalmente, il patrimonio comunicativo-verbale diffuso - abbiano come risultato (riscontrabile, ripeto, in qualsiasi ambito di vita) non una società che argomenta, che ragiona meglio, che pondera, capace di collegarsi e di compattarsi grazie alle parole, ma, esattamente al contrario, una sorta di fenomeno eruttivo, parole che zampillano da ogni pertugio, senza un disegno razionale, davvero senza un vero senso, per cui ci troviamo a condurre le nostre esistenze, tanto per colpa degli altri quanto per responsabilità nostra, in scenari che assomigliano alle satire della logorrea nevrotica e improduttiva dei membri della upper class presenti in certi film di Woody Allen.
Il rapporto intergenerazionale non è certo viziato da mutismo, io con i miei genitori parlavo molto meno, e viceversa, oggi si dialoga continuamente con i figli, intervenendo anche in campi che dovrebbero essere loro riservati, poi però il risultato è un difetto totale di intelligenza rispettiva. I luoghi di lavoro, soprattutto quelli di un certo terziario che si vorrebbe avanzato, sono diventati degli enormi laboratori di metariflessione e di logomachie fini a se stesse, a cavaliere tra analisi clinica freudiana e teatro dell’assurdo beckettiano (dove e quando le parole servono a scacciare lo spettro del Nulla), in cui, alla facciazza della produttività e della dignità del fare, si riempiono le giornate con cerebrali disquisizioni sulle relazioni interpersonali, sul benessere professionale, sui risiko carrieristici, immaginando che tutto questo straparlarsi addosso sia la cura, o almeno una medicina, mentre invece è, nove volte su dieci, la malattia.
Inutile dire, allora, che la deprecata deriva monologante dei social, in cui tutti scrivono e comunicano illudendosi che l’intera specie umana li stia leggendo o ascoltando, non è altro che la punta dell’iceberg di un mondo parolaio che, avanzato nelle tecnologie, tutelato nel diritto di espressione e culturalmente attrezzato, ha deciso, come certi accumulatori seriali che si seppelliscono a domicilio fra scartoffie e oggetti, di auto-tumularsi sotto uno strato spesso, solido e soffocante, di parole quasi sempre prive di un vero perché.




-2023-con-fotoOK-4.jpg)